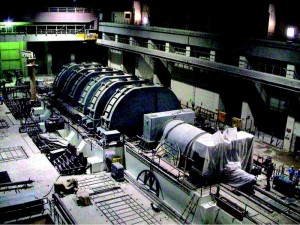Quattro società detengono il monopolio dell’arricchimento dell’Uranio.
1/3 dell’uranio usato proviene da stock militari in via di esaurimento, il restante da risorse in Russia, Canada, Niger e Australia, di cui l’85% dalle “sette cugine”
di Erasmo Venosi
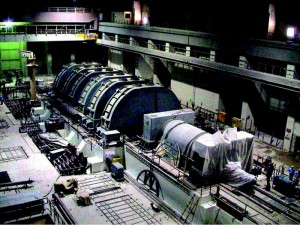
ROMA – Un elemento fondamentale nel dibattito sul ritorno al nucleare in Italia è stato oggetto di marginale discussione quando non di superficiale trattazione: le disponibilità effettive di uranio. Una fonte autorevolissima sull’argomento è la Technology Roadmap For Generation IV Nuclear Energy Systems, presentata dagli Stati Uniti nel 2002 e sottoscritta dai 10 Paesi partecipanti al programma della Generazione 4. Si tratta di un insieme di criteri per ottenere un reattore che sia sicuro (bassissima probabilità d’incidente ed eliminazione del piano di emergenza per la popolazione), economico e non proliferante.
Nel documenti Usa c’è un grafico che pone in evidenza il motivo per cui, per assicurare un futuro alla tecnologia nucleare civile, è necessario sviluppare la filiera dei reattori veloci autofertilizzanti, quelli che utilizzano l’uranio naturale per produrre un combustibile chiamato plutonio in quantità superiore a quella consumata.
Gli attuali reattori utilizzano nella stragrande maggioranza un particolare tipo di uranio che copre il fabbisogno (senza riprocessamento) fino al 2030, se si considerano le riserve note, o al massimo fino al 2060 considerando le riserve speculative (probabili o possibili). Stupisce la superficialità dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e della Nea, l’Agenzia per l’energia nucleare, che nello studio che quantifica le risorse di uranio, il cosiddetto Red Book, certificano le disponibilità di uranio. Incidentalmente va detto che tra le tipologie di reattori della Generazione 4 vi è la riproposizione di alcuni sviluppati senza successo negli scorsi anni (Msr, Gfr, Sfr, Vutr).
Prescindendo da questi dubbi resta l’evidente dato che nessuna di loro ha l’obiettivo di realizzare centrali in tempi brevi e di taglia funzionale alle condizioni vincolanti dei sistemi elettrici liberalizzati. Il dato su cui riflettere è l’entità dell’investimento necessario per il ritorno al nucleare. Ritorno che dipende dall’esito positivo della realizzazione dei reattori futuri ignorando consapevolmente l’esauribilità delle risorse di uranio, economicamente e termodinamicamente sfruttabili.
La sorprendente affermazione dell’estraibilità del metallo dall’acqua del mare cozza con i costi da sostenere ma soprattutto per la quantità di energia necessaria per tale impresa, che è superiore a quella ottenuta dalla fissione dell’uranio estratto. Le riserve conosciute hanno concentrazioni variabili tra i 2 chilogrammi in una tonnellata di roccia a 1 per 10 tonnellate, divise tra “facile” e “difficile” estrazione.
Nello studio condotto dagli olandesi Storm Van Leeuwen e Smith emerge che la quantità di energia da spendere per estrarre e lavorare l’uranio eccede quella ottenibile nei reattori ogni volta che dal giacimento si estraggono 3 chilogrammi di uranio lavorando 10 tonnellate di roccia. Il 40 per cento delle riserve è detenuto da Canada e Australia che, agli attuali ritmi di consumo, coprirebbero per un paio di decenni il fabbisogno delle centrali europee e americane. La restante parte di uranio è detenuta da Paesi come la Russia, il Niger e il Kazakhstan, mentre l’85 per cento è gestito dal cartello delle “sette cugine”.
E non irrilevante osservare che gli impianti di arricchimento dell’uranio sono in mano a quattro società: Areva, Urenco, Rosatom e Usec. Circa un terzo dell’uranio usato oggi proviene da stock militari esistenti e in via di esaurimento. Calcolare al di là di ogni altra considerazione, la convenienza economica del nucleare su un prezzo dell’uranio stabile è un azzardo inaccettabile per il nostro Paese.
Erasmo Venosi